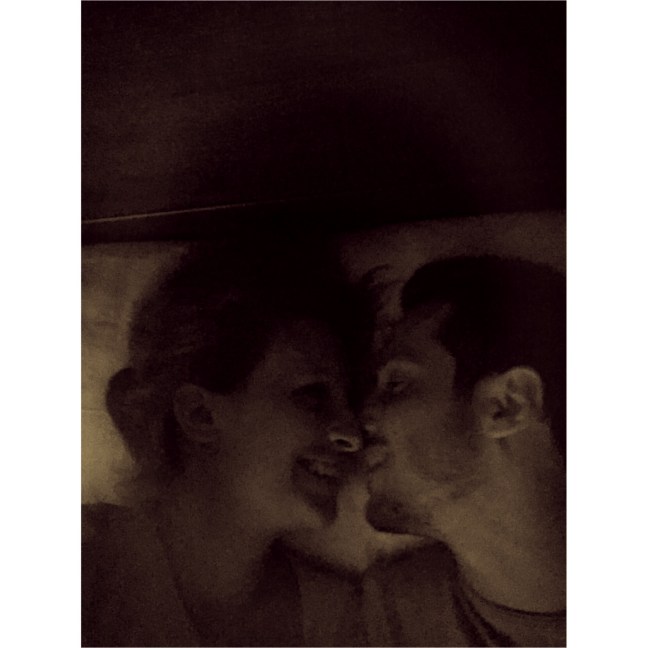Ore 5.27, la sveglia non è ancora suonata e io sto fissando il soffitto da qualche minuto.
Mi siedo e i piedi pendono dalla sponda del mio letto a castello, troppo alta ancora adesso che non ho più sei anni e che di centimetri ne ho presi in altezza.
In effetti sono piuttosto alta per essere una ragazza: di ventiquattrenni di 183 centimetri non se ne vedono tante in giro, specialmente nel paesino di provincia dove sono cresciuta.
A differenza di quanto si possa immaginare non mi sono mai vergognata della mia statura, anzi ne vado fiera: mia madre è sempre stata la più bella ragazza in circolazione, la più ammirata e invidiata, soprattutto per le lunghissime gambe che mi ha lasciato in eredità; gambe che ha sempre portato con estrema eleganza, a differenza di quanto faccia io che sono alquanto goffa e tutt’altro che graziosa.
Mi lancio dalla branda e atterro al centro della stanza. Non ho mai dormito sul letto più basso, forse per rispetto a quel fratellino che mamma mi aveva promesso e che non è mai arrivato o forse anche perché, abituata a vedere le cose dall’alto, mi sono sempre sentita al sicuro da sopra elevata.
Mi lavo, mi vesto velocemente e corro in cucina per la colazione dove mamma mi sta aspettando sorridente come tutte le mattine.
Una tazza di caffè, due uova sbattute, una fetta di pane tostato e siamo pronte per uscire.
Appena varcata la porta, il frizzante vento primaverile della mattina mi sorprende e mi fa lacrimare gli occhi, come se mi leggesse dentro e mi incoraggiasse a buttar fuori le mie emozioni. Guardo mamma e ricaccio indietro le lacrime: “questo vento mi rovinerà il trucco”, come se ne avessi mai fatto uso.
Procedendo verso il cancello, prendo mamma sotto braccio e mi faccio assalire dai ricordi di quando quel vialetto lo attraversammo per la prima volta, 19 anni prima, mano nella mano: rivedo i segni della buca scavata quando giocavo a essere un cane; le rose piantate per il progetto di scienze che senza l’aiuto di mamma, a quest’ora, sarebbero solo un groviglio di rovi; lo steccato dipinto per metà, negli anni in cui il giro in bici con gli amici aveva la priorità su qualsiasi faccenda domestica.
Da casa nostra, la fermata del pullman dista solo pochi metri e io inganno l’attesa accendendomi una sigaretta: non servono parole, lo sguardo severo di mamma mi concede pochi fiati e mi costringe a spegnerla.
Ore 6.15, l’autista apre le porte esattamente davanti a noi che ci guardiamo con aria nostalgica.
Non avrei mai pensato di trovare lavoro come modella, di dovermi trasferire lontano da casa e, soprattutto, di lasciare la mamma.
Ci facciamo strette, saliamo gli scalini e ci sediamo sui primi sedili a sinistra: mamma vicino al finestrino, io accanto al corridoio, come a proteggerla.
Il conducente riparte, ma in pochi secondi è costretto a inchiodare per aspettare la signora che si sta sbracciando rincorrendo il mezzo fuggiasco; tutti conosciamo Alfred: è l’unico autista della zona a essere sempre in anticipo sugli orari, sia di arrivo che di partenza.
Alfred, quasi infastidito, apre le porte a una signora di circa 60 anni che nel frattempo è
riuscita a raggiungere gli scalini: porta un golfino beige di lanetta usurata, poggiato sulle spalle, e sotto indossa un vestito bordeaux che lascia intravedere la corporatura robusta e forte di una donna che si è da sempre fatta aiutare “solo dalle proprie braccia”, o almeno questo è quello che mi raccontava spesso Antonia, quando veniva ad aiutare la mamma con le pulizie di casa.
“Alfred ti ho visto sai! Sei sempre in anticipo e mi fai correre come una pazza. Lo so che lo fai di proposito”. Alfred risponde con l’ennesima sbuffata, richiude le porte e riparte dopo aver controllato dallo specchio retrovisore che tutti i passeggeri siano seduti ai loro posti.
Il veicolo inizia a muoversi lentamente, quasi con angoscia, come se anch’esso volesse regalarci ancora qualche istante insieme.
La signora si accorge di noi poco dopo: “Tesoro caro! Non ti avevo vista! Che bella che sei anche di prima mattina. É oggi il grande giorno? Finalmente te ne vai da questa landa desolata?”.
“Si”, le rispondo serenamente. Antonia volge lo sguardo verso il sedile accanto a me e, sorridendo, saluta mamma con un cenno del capo. In men che non si dica siamo arrivati alla sua fermata: la dolce signora scende poco elegantemente dal sedile, si sistema il vestito, le porte si aprono e prima di affrontare i gradini si sporge per darmi un bacio sulla fronte. “A domani, Alfred”, l’autista richiude le porte così velocemente da non permetterle di finire la frase, sbuffa e riprende la marcia.
Noi non siamo tipi da chiacchiere: in tutti questi anni passati a spostarci con i mezzi pubblici non abbiamo quasi mai intrattenuto conversazioni di circostanza con gli altri passeggeri, non perché diffidenti, più probabilmente perché molto concentrate.
Il viaggio per noi, in effetti, ha da sempre un ruolo quasi mistico, un momento di analisi individuale, anche perché secondo mamma: “mentre canta Tracy Chapman è vietato parlare” e in macchina o nel nostro lettore cd condiviso non mi è mai stato concesso ascoltare altro.
Infilo le cuffiette, dopo essermi assicurata che mamma sia comoda, accendo la musica e spengo il mondo circostante.
Il mio sguardo si posa su una borsa semiaperta, ai piedi di una ragazza seduta nella fila dall’altra parte del corridoio; intravedo una scatola di biscotti e la copertina di un libro di cui leggo solo l’autore: “Herman Melville”. Purtroppo non riesco a scorgere di più e così provo a leggere lei: indossa un paio di vecchi jeans e una felpa verde con il cappuccio alzato sulla testa che lascia scappare una ciocca di capelli biondo chiarissimo. É intenta a guardare fuori dal finestrino e non si accorge di aver attirato la mia attenzione. Ha l’aria malinconica, ma allo stesso tempo forte e ostinata di una persona che ha ben chiara davanti a sé la strada che desidera percorrere. Potrebbe chiamarsi Ginevra oppure Cassandra, è in ogni caso una ragazza dal nome importante, regale.
“Ehm… sono Martha…”.
Oddio! Non ci credo ho pensato ad alta voce! E adesso come rimedio?
“Non preoccuparti: anche a me capita di far scappare i pensieri attraverso la bocca”, mi fa l’occhiolino.
“Io mi chiamo Julia”, recupero rispondendo con un sorriso.
“Ciao Julia, viaggi sola?”, mi sposto e lascio intravedere la mamma.
“Ah, viaggio importante. Dove siete dirette?”
Mi sento capita: “In un posto speciale per noi prima di salutarci”.
Mi sorride: “Mi raccomando, dille tutto quello che pensi”.
Alfred frena e Martha si sposta verso l’uscita.
“Ma tu dove stai andando?”, chiedo di fretta, alzando involontariamente la voce.
“Non lo ho ancora deciso”, salta giù dal pullman e sparisce fra le campagne.
La musica nelle cuffiette mi concilia il sonno, mi appoggio a mamma e mi addormento.
“July svegliati, siete arrivate a destinazione”. Apro gli occhi e Alfred è in piedi davanti a me.
“Siamo già arrivati?!”, chiedo stupita.
“Si piccola, hai dormito per un bel po’. È ora di scendere. Ci fermiamo mezz’oretta così potete salutarvi. Ti aspetto alla guida, e intanto mi leggo il giornale”.
Mi stropiccio, mi ricompongo, prendo mamma sottobraccio e scendiamo.
La collina di Benbulben si erge ripida sulla città di Sligo e per un momento quella vista mi lascia senza fiato.
Mi avvicino allo strapiombo, guardo mamma e scoppio in lacrime.
“Voglio che le mie ceneri volino sulle terre che ispirarono William Yeats, prima che tu
abbandoni questi luoghi e intraprenda la tua strada”, ripeto le tue parole imitando il tono della tua voce.
“Una promessa è una promessa”.
Apro l’urna, e lascio che quella polvere grigia scappi fuori e si liberi nell’aria.
“Arrivederci, mamma”.
FMS